Introduzione di Goffredo Giachini – Inizia da questo numero una rivisitazione di brani tratti dal libro “Macerata un tempo” edito nel 1986 da Il Labirinto, sulla vita in provincia, gli aneddoti, i caratteri, l’arguzia, le battute estemporanee dei… pistacoppi. E forniamo subito una sintesi di ciò che l’avv. Goffredo Binni, autore del gustoso volume, intendeva per quello che normalmente chiamiamo dialetto locale. Opinione che, in linea di massima, ci trova d’accordo. Per quanto riguarda i testi, saranno trascritti così come sono, senza spostare una virgola; togliendo tutt’al più qualche espressione di troppo, sostituendola, per la correntezza discorsiva del periodo con puntini di sospensione. Da notare che il Binni, da buon avvocato, evita di fare nomi o evocare nomignoli o soprannomi dei personaggi, ricorrendo alla formula “non si conosce, ma si sa chi è!” Il gioco gli riesce alla perfezione, sollecitando il ricordo o la curiosità di quanti non hanno vissuto tempi e circostanze.
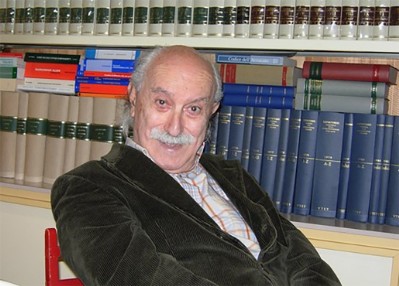
Cenni di Goffredo Binni sul dialetto locale – “Il linguaggio usato dalla “gente” è sempre un linguaggio disinibito, la forbitezza è lasciata solo a una postuma elaborazione. Per questo sovente è difficile ripetere battute sorte spontaneamente in quanto inconsciamente si procede alla loro rielaborazione: il tutto frutto di un ragionamento che si trova di fronte (…) al dilemma: o ripetere la battuta così come la si è sentita – e non sempre è facile ricordarla minutamente – o narrare la stessa in una forma dialettale propria di chi la ricorda cercando di usare il dialetto con un tono “puristico” come se esso fosse lingua parlata. Il dialetto invece non è mai pensato ed è e deve essere solo spontaneo, anche se, con il correre degli anni, si attua un fenomeno di imbastardimento del medesimo, sicché solo nei testi dei vecchi poeti dialettali è possibile una ricerca glottologica che abbia i caratteri della purezza. Il tutto senza tener conto che, anche a quei tempi il dialetto si stava imbastardendo a seguito del passaggio di truppe, di transizione di governi ecc. onde può veramente dirsi che ogni fenomeno cosiddetto “liberatorio (truppe piemontesi che cacciano i papalini – garibaldini che cacciano i Borboni – Austriaci che occupano le Marche a sostegno del Papa e così via…) è servito – posto che tale fenomeno possa chiamarsi servizio – ad alterare le radici profonde di un linguaggio, introducendo terminologie completamente nuove, a loro volta alterate, dialettizzate da un popolo che mal comprendeva il significato della nuova terminologia o comunque cercava di alterare assorbendo i nuovi modi di dire. Ci troviamo quindi di fronte a terminologie pensate, non più originali, non più spontanee, mentre un dialetto vero, ripetiamo, è solo un fatto spontaneo e la sua efficacia consiste proprio in un procedimento di sintesi idoneo a far comprendere, con brevissime battute, un determinato concetto sempre concreto, sempre reale. E, per dirla con Luigi Meneghello – uno scrittore che gli italiani dovrebbero assolutamente amare – ciò in quanto l’uso del dialetto contiene certe immediatezze che l’italiano non può contenere essendo insieme lingua parlata per alcuni e lingua scritta per la più parte che in italiano scrive”.
“Lavannàra donne!” – Oggi non sento più le voci di San Lorenzo: il marmista bianco, il calderaio, il fabbro, il richiamo di ogni lunedì “Lavannàra donne!!!” il cicaleccio serale fuori dell’uscio delle “donnette” sedute su sedie di legno e paglia portate giù in strada per scale strette. Un cicalare sommesso e acuto a un tempo; il discorrere di povere cose, del marito stanco che dormiva di sopra, del figlio militare, della vicina che doveva partorire – è un pezzo che è gravida – di corna, di piccoli amori, di morti vicini e lontani; un riandare indietro che si ripeteva di sera in sera in tutti i mesi estivi; e l’inverno lontano, e la neve, il gelo e la brutta caduta. Non erano le comari, erano le “donnette” dei vicoli, le donnette che conoscevano a memoria la storia di Macerata e del quartiere, una storia tramandata di generazione in generazione, in una tradizione orale che creava “mutazioni”, che ingrandiva o impiccioliva in relazione alla memoria, all’arguzia, alla malignità, sicché quello che non suscitava interesse in un racconto, diveniva “battuta” in un altro. (…) Era il tempo che quando moriva un contadino il maceratese cinico rispondeva all’amico che gli chiedeva: “ Chj è mmortu?” – “Gnisciù, un contadì”; erano i tempi in cui Macerata era tutto un quartiere e se abbiamo citato San Lorenzo è stato solo perché in esso siamo quasi nati, ché altrimenti potrebbe essere anche Ficana, o le Fosse, o la Cocolla, o le Casette e così via.
Monachette e limoni – A Macerata è sempre esistito il Convento delle Monachette, suore di clausura che, per le necessità esterne, si avvalgono dell’opera o di altre suore o di donnette che si prestano a far servigi sempre a titolo di carità. Tutti ricorderanno una certa “vinniricola”,buona donna di vasta mole, scanzonata e sboccacciata quel tanto che serva a caratterizzarla. Il banco era vicino al convento e un giorno due suorine si avvicinano e modestamente, umilmente, ma in modo chiaro da far intendere che desideravano non pagare (voto di povertà impone di non portare seco danaro), chiedono: “Ci potete dare due limoni per l’anime sante dei morti vostri?” La risposta è come al solito bruciante: “E cché li morti mia cià la cacarella?”. Inutile dire poi che i limoni furono dati. Ma le due suorine… forse ancor oggi e sono passati tanti anni, si segneranno”.
Lo sfollato – Era il tempo immediato della post-liberazione; se oggi esiste penuria degli alloggi a quei tempi -1945/46 – tra sfollati, sinistrati, inurbati, il vero imperatore era il commissario degli alloggi oppure il Sindaco. A quest’ultimo si presenta un noto sfollato maceratese e poiché non esisteva una statistica degli immobili disponibili e tantomeno di quelli nei quali, data la vastità, potevano essere sistemate due famiglie, il nostro sfollato segnala al Sindaco che in un certo stabile sito nel centro storico di Macerata una certa associazione di imprenditori aveva disponibilità di locali. Il Sindaco ascolta con immensa bonomia il di scorso e così risponde: “Va bene, provvederò subito però è necessario che lei mi fornisca il consenso del Presidente dell’organismo sindacale che occupa l’immobile”. Lo sfollato si reca presso la sede dell’organismo sindacale e chiede di conferire con il Presidente. L’impiegato risponde che in quel momento il Presidente è assente. Lo sfollato, che aveva urgenza di avere un tetto, chiede all’impiegato ove potesse trovare il sullodato Presidente. L’impiegato, che nulla sapeva, risponde: “È facilissimo, basta che lei vada in Comune e chieda del Sindaco, perché il Presidente di questa associazione e l’attuale sindaco di Macerata!” Lasciamo immaginare al lettore un certo tipo di reazione, ma certo è che in termini sportivi il gioco non era solo palleggio, bensì melina o manfrina della migliore qualità. La risposta data dal Sindaco era quella che si addiceva a un ottimo temporeggiatore, risposta politica idonea comunque a troncare un discorso e, se vogliamo essere eufemistici, uguale a quella che aveva usato a esempio “la vinniricola” per le due suorine.
Su per la Piaggia – Le vicende politiche a Macerata sono state sempre foriere di scherzi e scherni, mai nulla di grave ed è evidente che in una città ove in genere tutti si conoscono anche il pensiero e il voto di Tizio o di Caio è previsto con quasi assoluta certezza. A volte, però, il dubbio sorge, la curiosità stimola, e quando capita l’occasione, il terreno viene saggiato. Risparmio i nomi preferendo che siano i lettori a giungere alle singole individuazioni (…). Orbene si era sotto le elezioni e da parte di un “d.c.” (questo possiamo dirlo) si voleva sapere come avrebbe votato un conoscente; diciamo un conoscente “di passo”, non un vero e proprio amico. L’incontro avvenne su per la Piaggia della Torre (…) – ll “d.c.” affianca il conoscente, gli parla del più e del meno – il solito dire e non dire – non ha il coraggio di affrontare decisamente il tema, lo sfiora, gira e rigira e poi alla fine, tra il serio e il faceto lancia la battuta: “Ma dàje, che ttu si rusciu”. La risposta non tarda a venire, è secca e immediata, bellissima in quanto racchiude in sé un potere di sintesi che stronca (non tronca si badi bene) l’indagine del “diccì”: “Se tu vvò sapè se ssò rusciu, famme un tassellu llà lu culu”.
Racconti tratti da “Macerata un tempo” di G. Binni rivisitati da Goffredo Giachini
4 novembre 2021








